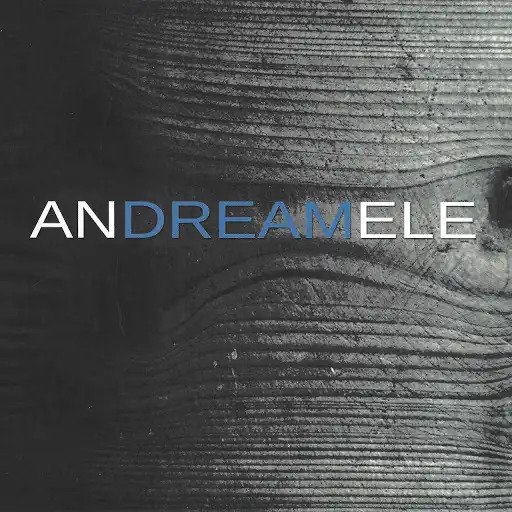Perché avremmo dovuto stare insieme tutta la notte. E ancora. Non avrei dovuto lasciarti andare.
Sto tornando a casa. Guido, da solo. Presto sarà giorno, ma è ancora buio. Quante luci: grandi, piccole, forti, deboli, bianche, gialle, rosse. Non ci fai più caso, in un certo senso non le vedi. Ce la immaginiamo sempre scura, la notte, con qualche stella, al massimo la Luna, e invece soprattutto lungo la strada, questa strada, è un fiorire continuo, quasi un affollamento. Insegne di negozi, lampioni, fari, altri lampioni. Poi ci sono quelle cosine intermittenti, di solito arancioni, che ci avvisano, ci ricordano di fare attenzione. Ma nulla spicca, è come una pianura distesa, placida e regolare, tanto che, appunto, non le noti più.
Sto tornando a casa e guardo avanti, verso l’orizzonte, dove sempre tutto finisce. O inizia. E vedo il limite, il bordo della notte, che sembra tingersi di rosso. Come una ferita, ma che non fa male, una ferita di luce.
Capisco improvvisamente, in un raro momento di epifania, che presto tutte queste luci che si affollano davanti ai miei occhi perderanno ogni senso, diventeranno ancora più piccole e deboli, e i loro colori sbiadiranno, appassiranno. Sento che mi manchi e vorrei che fossi qui, a guardare l’alba con me.
Sto tornando a casa e ora più che mai mi è chiaro come prima di incontrarti la mia vita fosse solo un rincorrersi di bagliori artificiali, forti o deboli, bianchi o gialli che fossero, fissi o intermittenti, e perché se non sei con me tutto mi pare piccolo e privo di significato, mentre quando ci sei mi sento non dico utile ma almeno completo.
Perché tu sei l’alba.